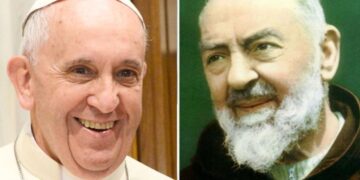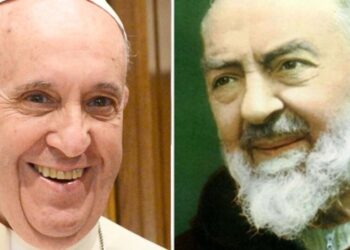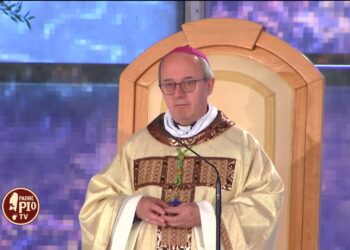La nostra storia
Suor Giuseppina Parma – Cenni Storici sulla congregazione delle MARCELLINE
Le suore di S. Marcellina – comunemente dette Marcelline – sono una congregazione religiosa di diritto Pontificio con finalità, alle origini, educativa.
1. Nome
Presero il nome da santa Marcellina (v.), sorella ed educatrice dei santi Ambrogio e Satiro, vissuta nel s. IV, scelta quale protettrice e modello per aver educato alla fede cristiana i minori fratelli, e per aver vissuto l’ideale della consacrazione verginale a Cristo con altre giovani da lei riunite nella propria casa a condividere lo studio delle sacre Scritture, la preghiera e le opere di carità
2. Fondazione
La congregazione fu fondata nel 1838 a Cernusco sul Naviglio (Milano), dove l’allora direttore spirituale del seminario maggiore, don Luigi Biraghi aprì un convitto per fanciulle di condizione "civile", affidandolo alla cura di quattro giovani maestre dirette da Marina Videmari e come lei decise di vivere la consacrazione religiosa, istruendo ed educando a vita cristiana le alunne.
3. Erezione Canonica e Regola
Dopo la prima approvazione, nel 1839, dell’arcivescovo di Milano cardinal Gaetano Gaisruck, l’Istituto, che nel 1841 aveva aperto un secondo convitto a Vimercate (Milano), grazie al generoso interessamento del conte Giacomo Mellerio (1777-1847), ottenuta l’autorizzazione imperiale, come d’obbligo nel regno Lombardo-Veneto, nel 1852 fu eretto canonicamente dall’arcivescovo mons. C. Bartolomeo Romilli, che presiedette alla prima professione pubblica delle religiose, alle quali consegnò la Regola per loro redatta dal Fondatore col titolo Regola delle suore Orsoline di s. Marcellina nella diocesi milanese [….]
Il nome di Orsoline dovette essere premesso alla specificazione di S. Marcellina, non essendo permessa,dopo la soppressione degli ordini religiosi del 1810, la fondazione di nuovi ordini, ma solo la restaurazione degli antichi. Il Biraghi, quindi, si rifece all’istituzione cinquecentesca delle Orsoline di S. Angela Merici, ben vista dagli arcivescovi milanesi succeduti a S. Carlo, ed anche dal cardinal Gaisruck.
Questa Regola, che ebbe una seconda edizione nel 1875 con l’aggiunta di un Costumiere redatto da madre Videmari, per ottenere l’approvazione pontificia fu successivamente rielaborata secondo le disposizioni del diritto canonico e definitivamente approvata nel 1899.
Nel 1921, in ottemperanza al nuovo Codice di Diritto Canonico, ne fu fatta una nuova edizione, divisa in due parti: Costituzioni e Direttorio.
Nel 1980 fu approvato il testo delle Costituzioni e delle Norme dell’Istituto delle Suore di, elaborato durante il Capitolo Speciale del 1968-1970, in ordine al rinnovamento della vita religiosa secondo il Concilio Vaticano II.
4. Fine e carisma dell’Istituto
Il Fondatore finalizzò la congregazione delle Marcelline all’educazione delle fanciulle, per una precisa scelta di apostolato.
Consapevole dell’importanza che veniva ad assumere la donna nella società moderna, in progressivo allontanamento dalla fede per influsso delle ideologie atee e rivoluzionarie della fine del s. XVIII e degli inizi del XIX, egli vide la sua formazione cristiana nell’età scolare come mezzo per una nuova cristianizzazione della famiglia e della società.
"Il fine pel quale, ajutando Dio benedetto, venne istituita questa pia Congregazione – si legge nel Prologo della Regola- fu di ben educare le fanciulle, dalla cui cristiana e civile riescita dipende in tanta parte il bene della Chiesa e dello Stato"
"E perocchè – continua il testo- l’officio di educare è santo, difficile e tale che richiede molta abilità, esempi edificanti, assoluto disinteresse e sacrifici continui, perciò vengono opportune all’uopo le Congregazioni Religiose, dove unita insieme la pietà e la scienza, nella concordia degli sforzi, nel solo interesse del bene, si attende di proposito a sì rilevante ministero".
La Regola, pertanto, ha doppio scopo: offrire alle suore tutti i mezzi per vivere in pienezza la consacrazione religiosa e tutti i mezzi per allevare le alunne "nella sincera bontà cristiana, nei lavori più utili della famiglia e negli studi convenienti ad oneste fanciulle".
Di qui la singolarità della vocazione religiosa "marcellina", nello stesso tempo di vergini consacrate e di educatrici, impegnate ad essere "sante per educare" ed a "farsi sante" nell’opera educativa.
In tal modo il Biraghi faceva, della sua, una congregazione di vita mista, proponendo alle destinatarie della sua Regola di unire insieme gli esercizi propri delle claustrali con le opere delle suore di vita attiva: nel loro caso quelle relative all’educazione delle alunne. Per questo, oltre alla patrona s. Marcellina, diede loro come modello le due sorelle del Vangelo Marta e Maria, rappresentate nella lunetta sovrastante il portone del primo collegio in Cernusco, tradizionalmente indicate come simboli della vita attiva e della vita contemplativa.